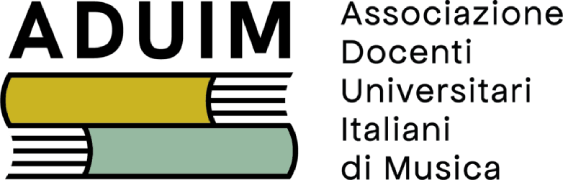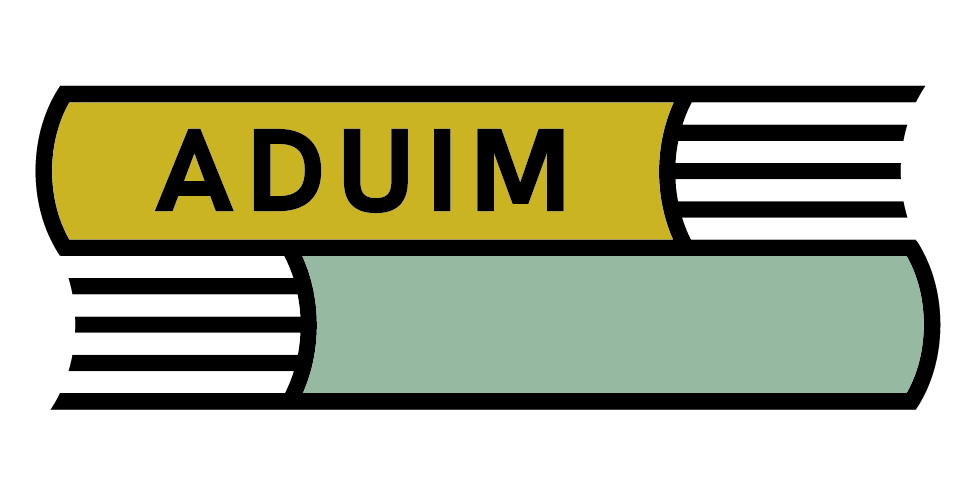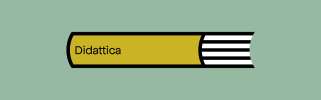Ultimi Articoli
-
II Meeting ESCOM-Italy – Call for Paper
10 Luglio, 2024 -
Bandi dottorati di ricerca in discipline musicali
20 Giugno, 2024
25 Giugno, 2021
in Tutte le News
Sesta edizione premio “Tesi rossiniane” (30 giugno 2021)
15 Giugno, 2021
in Tutte le News